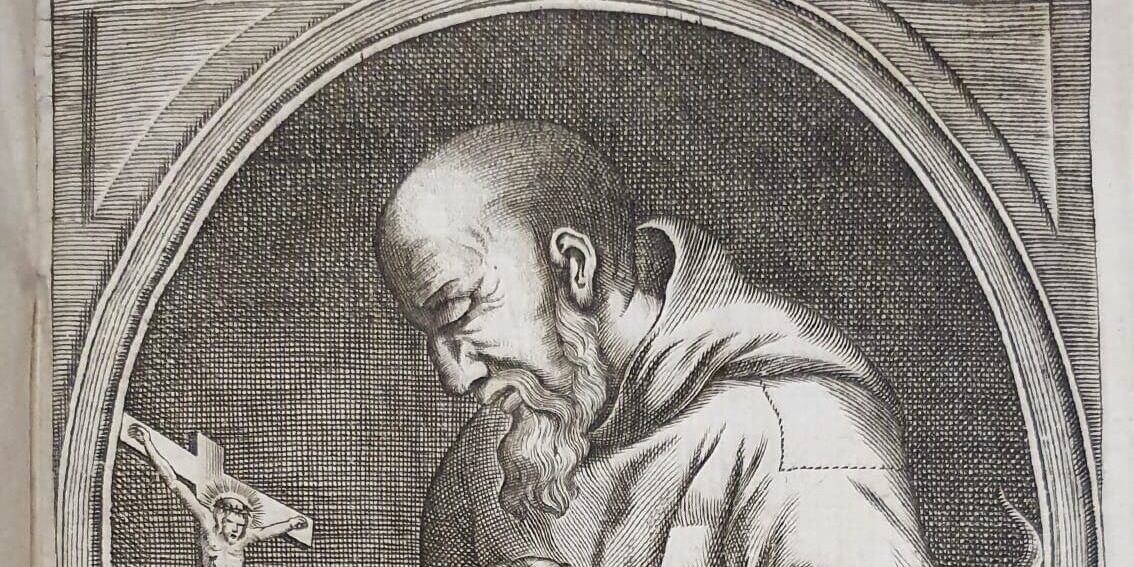Come ogni martedì torna la rubrica dedicata alla figura di Tommaso da Olera, il frate cappuccino vissuto a cavallo tra Cinquecento e Seicento e proclamato Beato nel 2013. Il testo è tratto da “Tommaso da Olera, un anno con un mistico del Cuore di Gesù” di Sergio Calzone. Le riflessioni di oggi.
La riflessione
Scala di perfezione è un esempio, insieme, di pietas e di intransigenza: da una parte, Fra Tommaso mostra di conoscere tutte le debolezze umane e di comprendere perfettamente come non tutti possano essere «atleti di Dio», ma, allo stesso tempo, è impossibile trovare, nei capitoli che si susseguono apparentemente lenti ma caratterizzati da una logica agostiniana, una qualche indulgenza nei confronti di coloro che vogliano davvero salire questa «scala», verso la perfezione cristiana: nessun compromesso è loro concesso poiché così deve essere, per poter mirare al risultato più grande cui si possa ambire nel corso della vita terrena. Egli insegna anche a diffidare da certa religiosità che, diremo, «di riflesso» si suscita nell’animo di fronte al mistero della morte: è una religiosità magari sincera nelle intenzioni ma non originata da una purezza autentica dell’anima, bensì dalla pur comprensibile ma non scusabile paura per l’ignoto. Si tratta, cioè, di una sorta di fede utilizzata come «garanzia»: la mia anima sia, d’ora in avanti, più rivolta a Dio non perché io senta una reale attrazione verso di Lui, ma perché ciò può essere prudente farlo in vista di un aldilà che non so dipingermi ma a cui, se davvero comporterà un giudizio sul mio operato, è meglio giungere preparato.
La conversione per paura
La conversione per paura, dice in sostanza Fra Tommaso, ha scarso valore perché è pur sempre mossa dall’egoismo, non dal disinteresse dell’amare Dio per Dio, e non per acquisire meriti da «spendere» al momento del giudizio individuale: soltanto Dio sa trarre anche da questo un’occasione per attrarre a sé un peccatore che, però, dovrà farsi parte attiva e non accontentarsi di quello che è soltanto un primo passo.
E dirò per essempio: ti trovi alla morte d’un tuo parente overo amico; entro di te stesso sarai ferito di timore della morte e ti rissolverai di mutar vita, perché quello che è avvenuto oggi al tuo parente o amico dimani verrà anca a te. E con questo sentimento ti converti per timor della morte, per paura dell’Inferno overo per andar in Paradiso; ed in questa prima conversione Dio non v’averà parte, ma il solo interesse, ed il solo amor proprio v’averà che fare, con tutto che sia l’uomo mosso con interesse si può dir che li sia qualche bontà, perché comincia la via che da questi interessi sarà tirata da Dio ad un altro lume maggiore, che li darà lume del vero amor di Dio: ov’a poco a poco anderà perfezionando quel ch’era amor proprio, lo convertirà in amor di Dio. Ma sappi che, quando non passerai oltre e che ti fermerai in quest’amor, che nulla averai fatto: e però io t’essorto che, quando sarai convertito per interesse, dei passar più oltre, lasciando la strada dell’amore servile che non ti può dar alcun bene. (Scala, 125-126)
A maggior ragione, una conversione all’ultima ora, dettata dal concreto timore del passaggio dalla vita alla morte, non è altro che il tentativo di «salvare il salvabile», in una contrizione che vorrebbe evitare la «mala morte», cioè la morte in peccato mortale, ma, ancora una volta e, se mai, di più, per opportunismo, egoismo, senza alcuna vera vocazione alla perfezione morale. E non importa ciò che dirà la gente, magari ingannata da una frase, da un gesto: Dio vede l’uomo nell’anima e conosce tutti i suoi moventi e non si lascerà certo ingannare da meschine astuzie.
E però quello il qual è stato di mala vita, mentre si vede moribondo e morendo lascia di sé mala fama, mall’odore, vorrebbe la natura corrotta riffarsi in quel poco di tempo che li resta; ove l’amor proprio, del qual sempre è stato patrone, l’assalisse e molte volte li farà dire parole di Dio, li farà far atti di santità acciò morendo si dica: «Il tal è morto santamente, ha deto “Gesù!”, è morto con tanta contrizione c’ha fatto stupire». E così la natura viziata, corrotta per i mali abiti, pretende a questo modo di riffarsi e, non avendo acquistato fama mentre viveva, pretende di riffarsi almeno doppo morte: perché la natura dell’uomo cerca tanto se stesso che per un tantino di gloria mondana anderà per fillo di spada. E molte volte l’uomo inesperto, mosso d’amor proprio e suo proprio interesse, farà e dirà nell’ultimo della vita sua cose tali che chi vedrà restarà molto edificato; nientedimeno aggiongeranno vizio a vizio, peccato a peccato, e molte volte gl’assistenti diranno parole: «Oh come muore bene! Oh, sia benedetta quell’anima! Oh come anderà in Paradiso!», con altre simili parole. Ove il poverello, pieno d’amor proprio, avendo vissuto con mali abiti, aggiongendoli le tentazioni diaboliche, si vanagloria, cascherà in superbia, e così la salute di quel tale sarà disperata. E però questi tali bisogna tenerli bassi; e quando diranno e faranno cose di santità, mostrando esteriormente allegrezze, parole di Dio, bisogna avisarli e darli lume dell’amor proprio, facendoli far atti interni, mostrandoli il pericolo, dandoli lume dell’amor puro di Dio, e che in quel punto si guardino dall’amor proprio, dagl’interessi della proprietà e della vanagloria, tenendoli bassi, mortificati, dandoli lume della contrizione filiale, con la qual in quel stato solo ne può far amici di Dio e salvarsi, ancorché gran peccatori fusse, esser vigilanti a non acconsentir giamai a dire o far cosa che non sia in Dio e per Dio: perché in quel punto consiste ogni nostro bene ed anco male, sì come si legge d’uno il qual, essendo in transito, sentì a dire: «Oh come muore bene, oh beata quell’anima!»; ove il poverello, sgonfiandosi di vanagloria, acconsentì. Ove spirando quell’infelice anima, morse dannata. (Scala, 109)
Ecco che allora, quasi come conseguenza naturale di queste considerazioni sulla fallacia di certe conversioni che possono ingannare gli uomini ma non certo Dio, emerge, in Scala di perfezione, la necessità di trattare della natura del Purgatorio e delle argomentazioni da esso indotte
Com’è noto, nel 1981 Jacques Le Goff, uno dei maggiori medievisti francesi del Novecento, pubblicò il volume intitolato La nascita del Purgatorio[1] in cui, testi alla mano, dimostrava «l’invenzione» del «regno di mezzo» da parte dei teologi del XII secolo. Egli spiegava questa sorta di esigenza con il mutare della società medievale alla fine del periodo feudale: «L’antica opposizione tra ricchi e poveri, potenti e deboli, inizia a modificarsi con l’emergere di una fascia intermedia. Nella gerarchia sociale, tra signori e sudditi, si profila la categoria dei borghesi». Il fatto, poi, che molto presto il genio di Dante si fosse impadronito di questa acquisizione e ne avesse fatto oggetto della seconda cantica del suo capolavoro costituì, sempre secondo Le Goff, la consacrazione di questo «terzo luogo», adatto alla mentalità mercantile della «contrattazione»: «La forza del poema dantesco ha contribuito in maniera decisiva ad ancorare nell’immaginario collettivo l’esistenza di questo “terzo luogo”, la cui nascita era tutto sommato recente».
La Chiesa ha confutato con forza le affermazioni di Le Goff. Se è ben vero che nessun testo sacro parla in modo esplicito del Purgatorio, né, tanto meno, utilizza tale termine, sono però citati i sacrifici, durati trenta giorni, dopo la morte di Aronne, come esempio che dimostra come sia possibile espiare i propri peccati anche nell’aldilà. Pure Giuda Maccabeo fece pregare per i defunti, dimostrando che anche l’Antico Testamento credeva che i defunti potessero espiare colpe di media gravità.
[1] J. Le Goff, La Naissance du purgatoire, Paris, Gallimard, 1981 (La nascita del Purgatorio, traduzione di Elena De Angeli, Torino, Einaudi, 1982).