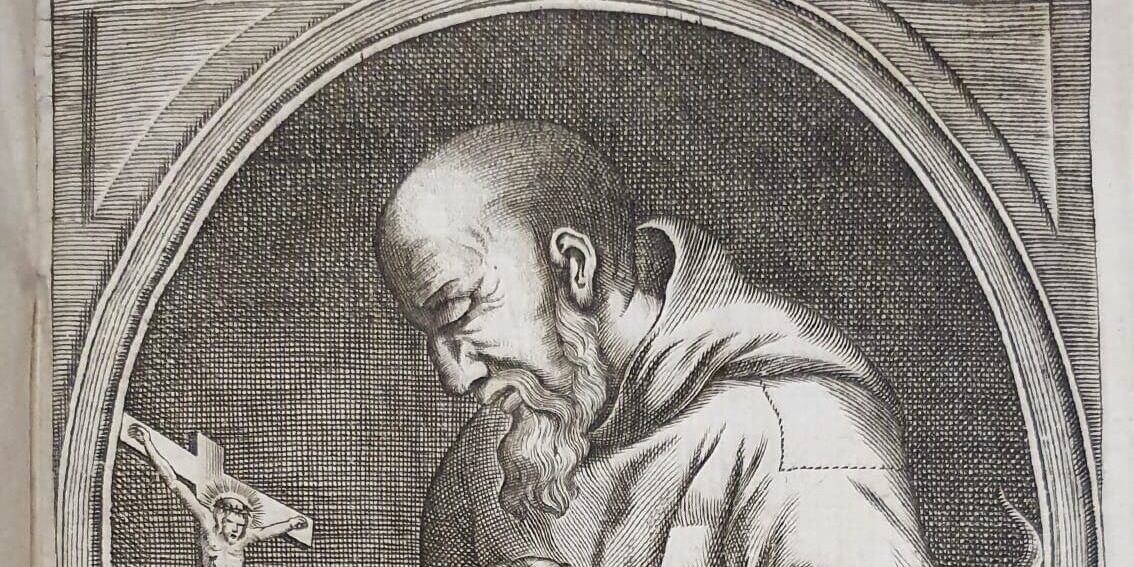Come ogni martedì torna la rubrica dedicata alla figura di Tommaso da Olera, il frate cappuccino vissuto a cavallo tra Cinque e Seicento e proclamato Beato nel 2013. Il testo è tratto da “Tommaso da Olera, un anno con un mistico del Cuore di Gesù” di Sergio Calzone. Le riflessioni di oggi.
Resta da accennare ciò che, in ultima analisi, distingue Fra Tommaso da santa Margherita-Maria Alacoque, di cui lo stesso Badan, ricordato in apertura, asserisce essere il Beato un precursore. Mentre la santa riceve visioni divine e rivelatrici, Fra Tommaso arriva a quella consapevolezza per via di mistica che, tuttavia, nella sua umiltà, egli non attribuisce alla propria intuizione.
Questa sapienza e scienza che il Padre eterno ha rivelata alli piccioli più s’impara nelle piaghe di Cristo che in ogn’altro modo; però dice il nostro Dio: «Chi ha sete venghi a me e bevi [Gv 7,37]». Questa divina fonte alla quale c’invita tanto è il cuore spalancato di Gesù Cristo nostro amantissimo Dio, ove hanno bevuto tanti santi quali ora godono il suo celeste canevaro Iddio. A questa ha bevuto quel serafico dottore S. Bonaventura, perché, andando l’angellico dottore S. Tomaso d’Aquino a visitarlo, lo domandò tra l’altre cose particolarmente che gli mostrasse la sua libraria; e pensando di vedere una bellissima ed amplissima copia di libri, lo menò S. Bonaventura nella sua cella e mostrogli il crucifisso, dicendo a S. Tomaso: «Padre mio, questa è la mia libraria, della quale io imparo la vera sapienza; e tutti li santi e gran litterati hanno imparato a questa scola». (Scala, 188)
Egli, dunque, si mantiene fedele al proprio «metodo»: la semplice contemplazione delle piaghe di Cristo.
Che cosa è estasi se non una morte di stupore, d’amirazione, vedendo in Dio tanta carità, tant’amore verso a creatura tant’ingrata e sconoscente? E chi potrà mai capire l’amor di Dio? Forsi li più elevati intelletti, forsi li più perfetti? Non per certo: questa scienza dell’amor di Dio sola è risservata a lui, e lui solo può capire questo eccesso di carità ed amore. (Scala, 156)
Certo, resta la distinzione tra Fra Tommaso e Margherita-Maria Alacoque, sempre sottolineata, in questi casi: mentre il primo porta avanti un colloquio «privato» con Dio, la seconda è capace di farne partecipe l’intera comunità cristiana, ma quanto valore è contenuto comunque in parole come queste, che possono essere poste a sigillo della sua esperienza d’estasi.
Tutta la perfezione cristiana consiste nell’amore: o beati, o felici voi innamorati, poiché con l’amore trovasti l’innamorato Dio! In questo amore consiste la gloria eterna o la dannazione eterna. O felicità de li innamorati figliuoli, poiché sete seguiti una via piena, colma di delizie, le cui delizie nascono dall’innamorato Cristo, dicendo: delitiae meae esse cum filiis hominum [ponendo le mie delizie tra i figli dell’uomo (Prv 8,31)]. (Scala, 178)
Pare quasi che a lui e ad altri come Fra Tommaso pensasse Joseph Ratzinger, quando, già papa, diceva: «I beati e i santi sono stati persone che non hanno cercato ostinatamente la propria felicità, ma semplicemente hanno voluto donarsi, perché sono state raggiunte dalla luce di Cristo. Essi ci indicano così la strada per diventare felici, ci mostrano come si riesce ad essere persone veramente umane. Nelle vicende della storia sono stati essi i veri riformatori che tante volte l’hanno risollevata dalle valli oscure nelle quali è sempre nuovamente in pericolo di sprofondare; essi l’hanno sempre nuovamente illuminata quando era necessario per dare la possibilità di accettare – magari nel dolore ‒ la parola pronunciata da Dio al termine dell’opera della creazione: «È cosa buona»»
Le Tre Persone: chiarezza sullo Spirito Santo
Il primo accenno alla Trinità, nelle opere di Fra Tommaso, compare quando egli ribadisce ancora una volta, in Selva di contemplazione, la necessità di avvicinarsi a Dio non tanto con la lettura dei libri, quanto in altro modo.
E se bene vuoi studiar, leggi frequentemente quelli cinque libri delle piaghe del crocefisso, poiché altra strada non puoi trovare che il camino di questo appassionato Cristo, il quale maestra li suoi scolari nella solitudine dell’amor suo, tingendo la pena nel calamaro del suo costato, scrivendo entro al tuo cuore la dura ed aspra morte del tuo redentore, legendo tutto il tempo della vita tua la passione e morte del tuo Cristo, piangendo e gemendo, e pregando questo Dio con tanto maggior amore. A gloria dell’eterno Dio, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, tre persone ed un solo Dio. (Scala, 112)
Ciò corrisponde, del resto, alla nitida visione di sant’Agostino: «Le persone divine non sono più di tre: la prima che ama quella che da lei nasce, la seconda che ama quella da cui nasce e la terza che è lo stesso amore».
Poiché questo è un punto centrale del credo cristiano, non infrequentemente messo in discussione, ad esempio, dai commentatori musulmani che vi vedono come un’ombra (e forse più) di politeismo, sarà importante leggere gli scritti del beato Tommaso anche da questo punto di vista.
La questione di una presunta «gerarchia» divina è tuttavia liquidata ben presto da Fra Tommaso, con una frase tanto breve, quanto chiara e, a parer nostro, definitiva: «O gloriosa Madre de Dio, regina di angeli, figliola de l’eterno Padre, sposa dello Spirito Santo. (Selva, 245)
Attraverso la figura di Maria si viene dunque a definire l’esatta identificazione delle tre Persone in una sola natura, ancorché lo Spirito Santo, per la nostra sensibilità (e, dunque, fallace e limitata), sia sempre un poco meno nitido, nella sua definizione, tanto che lo stesso Fra Tommaso frequentemente omette di citarlo.
Voglio io ben credere che, aprendosi il cielo, venero le moltitudine de gli angelli i celesti a schiere, cantando e giubilando, lodando il loro Dio, e genuflessi adoravano l’agnello Cristo; quele beate anime de’ santi padri si ralegravano con essi de la libertà loro. Oh come godeva la Santissima Trinità in veder quela beata umanità! Godeva il Padre eterno in veder l’unigenito suo figliuolo acompagnato da quele beate spolie de li demoni con li santi padri; godeva Cristo in veder che aveva compiuto la obedienza de l’eterno suo Padre. Oh che avesse veduto con che pompa e gloria ressussitò il nostro amantissimo Cristo! Ognuno contempli questo misterio ralegrandosi de la gloria e allegrezza del nostro Dio. (Selva, 261-262)
Le azioni del Padre
Qui appare evidente che, dopo aver reso soggetto dell’azione la «Santissima Trinità», in realtà egli mostra le azioni e i pensieri (se così si possono definire) del Padre e dell’«unigenito suo figliuolo». Fino a rischiare l’incidente letterario.
Fu riceuto Gesù da l’eterno Dio Padre: li angeli del cielo giogivano in veder quella beata umanità del suo Dio, vedevano quelle feritte che riempivano il cielo di splendore. Portavano li misteri li santi angeli de la passione del Signore figlio di Dio e prostrati a’ piedi del loro Dio lo adoravano, lo benedicevano, vedendo quella umanità che Lucifero non volse adorare. Oh, fece al suo eterno Padre la obedienza la sua passione e morte, ringraziandolo di quanto aveva fatto per mezo suo; ringraziava il Padre il figlio della ubedienza fata, per mezo della qualle aveva redento il genere umano: ove con gloriosa maestà andava l’eterno Dio salendo di coro in coro di quelli santi angeli. Io non so quale de’ doi fusse magior: era l’eterno Dio in cielo accompagnato da tutti li angeli; andava l’unigenito figlio di Dio nel suo trono accompagnato da numero grande di angeli che erano dissesi dal cielo a ricever il loro Dio: ma di più aveva il filiuolo di Dio numero infinito di santi padri e anco molte anime che Cristo aveva liberate dal Purgatorio. Tutte queste accompagnavano il Signore: erano patriarchi, proffetti, ove quasi concorevano con quelli angeli celesti in adorare l’agnello, in lodarlo, in benedirlo, ove ognuno concoreva a chi più poteva onorar il suo Dio. Ogni coro di angeli, ove passava quella Santissima Trinità, ognuno faceva la parte sua, onorando, lodando, adorando il suo Dio trino e uno. Oh quanta allegrezza e aplauso facevano quelli angelici cori! Intonavano tuto il cielo. (Selva, 283)
Qui è ben chiaro come si dica «Io non so quale de’ doi fusse magior»: dei due, mentre poco dopo «passava quella Santissima Trinità». Infortuni che è facile e credibile attribuire alla foga con la quale procedeva la scrittura del beato Tommaso.
Altrove, infatti, lo Spirito Santo è bene presente: in primis, ovviamente, nel mistero della Pentecoste, episodio che Fra Tommaso liberamente deriva dagli Atti degli Apostoli, 2.
E se bene molte volte li era parso e aveva trattato con essi, erano nondimeno spaventati per la crudel morte che avevano veduto che li Ebrei avevano datto al suo maestro. Ove, se bene erano stati consolati per la apparizione del suo Signore, gli era nondimeno rimasto uno timore, uno spavento che gli teneva occupati.
O caro Dio, non potevi levargli ogni timore con un minimo atto della voluntà vostra? E perché volete voi che siano così spaventati? O Dio de l’anima mia, veggio che questo è tutto amor vostro, perché cercavi la pienezza delle loro consolazioni a la venuta dello Spirito Santo, acciò fossero ripieni di allegrezze e nottassero a guisa di pesse che notando nelle acque: così voi, Dio mio, cercavi la completa alegrezza nelle anime, nei cori delli apostoli istessi a quella santa venuta e anco volesti ricercare li apostoli a guisa di torrente che, scorrendo con velozze corso, inonda l’arida terra facendo germoliar frutti in abondanza. E però, essendo li vostri apostoli aridi di spavento, reservasti a essi il torrente dello Spirito Paraclito acciò, inondando questi campi aridi delli vostri apostoli, inondasse anco in essi la letizia e i giubili, scacciando da essi ogni timore, sì come al suo loco tratterò. (Selva, 276-277) (65)